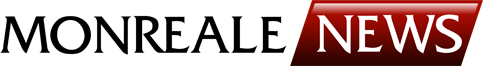Amarcord di migliaia di partite giocate come se fosse la Coppa Campioni
MONREALE, 12 agosto – Storia di partite combattute, dal risultato indefinito e dalla durata imprecisata. Storia di palloni arroccati, bucati, o più dolorosamente, tagliati. Di gol-fantasma, che… manco il Var, di regole inventate, di un lessico sui generis.
Erano le partite che si giocavano per strada, quando i campi di calcetto non esistevano, ma soprattutto quando le macchine passavano alla media di una ogni ora e bastava uno spiazzo, oggi purtroppo un parcheggio intasato, per sentirsi a Wembley o a San Siro.
Il principale di questi a Monreale era a piazza Fedele, dove nel senso longitudinale dell’area sorgeva quello che per tutti i calciatori da strada dell’epoca era “O’ Sinnaco”. I ragazzi di oggi probabilmente lo conoscono solo come un parcheggio comunale a pagamento, spesso pieno di auto, ma prima, come l’ “Old Trafford” di Manchester, per i ragazzini monrealesi quel luogo era il “Teatro dei Sogni”. Il campo era delimitato dal palazzo attiguo da una parte, dal marciapiede dall’altra (in senso longitudinale), mentre in larghezza dal muretto sottostante il marciapiede di via Kennedy come “linea” di fondo da una parte e da quello sotto piazza Inghilleri dall’altra. Insomma, un campo secco e lungo, dove per forza di cose, non esistevano le fasce laterali, ma si giocava solo in verticale.
Le partite cominciavano con il “toccarsi i compagni”, prassi necessaria per formare le squadre. Il rito, quello che in altre parti d’Italia si chiama “Bim Bum Bam”, vedeva protagonisti i due “capoccia” della situazione contrapposti che, ad uno ad uno, sceglievano a turno il compagno da inserire nella propria squadra, ovviamente procedendo in ordine di bravura. E così, i primi ad essere scelti erano sempre i più forti, poi, via via, si andava avanti con quelli meno bravi. Se il numero dei partecipanti era pari, tutto ok. Diverso il discorso se i giocatori erano dispari. L’ultimo che restava senza essere stato scelto, ovviamente il più scarso, o presunto tale, doveva subire l’onta della “sfasciata a cannavazzo”. In pratica la squadra che in extremis lo poteva reclutare giocava in superiorità numerica, ma doveva accontentarsi di un giocatore verosimilmente impacciato o, per dirla pulita, con poca dimestichezza col calcio. O, come dicevamo noi, "sciarriatu cu palluni". Quello però doveva giocare obbligatoriamente, perché nella maggior parte dei casi era quello che portava il pallone.
Data la presenza dei muri laterali, era ammessa la “sponda”, ovvero un “auto-triangolo”, che serviva a saltare un avversario o a servire un compagno. E le porte? Qualche “balatone” raccattato lì nelle vicinanze per fare i pali, ma andavano bene anche gli zaini della scuola, che le delimitavano in maniera “oscillante” rendendo l’ampiezza variabile, a seconda dei casi. A volte, poi, passava lo “sconzajoco” di giornata, che si divertiva furtivamente ad allargare la porta, spostando col piede ciò che fungeva da palo. Tutto questo fin quando i partecipanti non si accorgevano del boicottaggio: in quel caso scattavano le spedizioni punitive che prevedevano che al colpevole venisse inflitta una sanzione consistente di solito in una “fracchiata” di legnate. In subordine era prevista un'alitata in faccia (ovviamente in maniera coatta), da parte di uno dei partecipanti, noto per avere un fiato pestilenziale (del quale, tra l'altro, si vantava...).
Ovviamente la traversa non c’era e l’altezza della porta era delimitata a occhio, a seconda dell’altezza del portiere di turno. Se questi era un “trangalone” poteva essere considerato gol anche un tiro nello specchio della porta passato ad altezza considerevole. Discorso diverso se in porta c’era uno “corto”. In quel caso un tiro che passava anche a circa un metro e ottanta dal suolo, veniva considerato alto, tra le proteste, inevitabili, della squadra che attaccava. Proteste e discussioni che divampavano anche perchè non c'era un arbitro. Primo perchè non voleva farlo nessuno, perchè tutti volevano giocare, e poi perchè, anche se ci fosse stato, non lo avrebbe ascoltato nessuno. Ragion per cui le regole erano molto ballerine, impartite dal "toco" dela situazione o dal più bravo della compagnia.
Chiaramente le partite non avevano una durata fissa, ma si concludevano di solito al raggiungimento di un punteggio prestabilito. A "cinque" o a "dieci", per esempio. Fine che veniva rinviata, verosimilmente, se la squadra del bulletto della situazione stava perdendo. Poi c’era la rivincita, perchè la prima è "ri picciriddi” ed eventualmente la bella.
E che dire della terminologia? Un frasario da inglese maccheronico indicava alcune situazioni di gioco: “Enzi”, per esempio, era il fallo di mano (dall’inglese “hands”, mani), così come di matrice britannica era la “palla a due” (quando l’arbitro la scodella in mezzo a due giocatori contrapposti per riprendere il gioco dopo una sospensione). Il termine ufficiale è “free kick”, che in siciliano diventava “u frichicchiu”, cioè, appunto il rimettere la palla in gioco per riprendere le ostilità, dopo una sospensione avvenuta, nella maggior parte dei casi, perché era passata una macchina o per dirimere una controversia non risolta in altro modo).
In queste partite epiche il pallone “official” era il mitico “Super Santos”, ma in mancanza di esso poteva andare bene il “Super Tele”, un po’ più leggero. Non buono, invece, il “Telesport”, del quale era impossibile prevedere la traiettoria a causa della sua leggerezza e della sua irregolarità”. Tanto che un tiro in porta poteva concludersi da tutt’altra parte. Anche in un balcone del vicinato. Ed era allora che partiva la richiesta canonica: “Signoraaaaa? Ce lo dà il palloneeee?” Già, ce lo dà….. Una parola…. Qui cominciavano i guai, perché spesso si presentava il marito della signora, con tanto di canottiera e pantofole, e pronunciava la temutissima fase: “Chi ffa u tagghiamu stu palluni? Era questa la minaccia più grossa che potesse arrivare ed insieme l’oltraggio più pesante che si potesse subire. Lanciata a volte, anche, a mo’ di deterrente, da qualche adulto che stava nei pressi del campo, magari infastidito dagli schiamazzi o seccato perché qualche pallonata aveva colpito la sua macchina. Chi dei ragazzi di quel tempo non ha avuto tagliato almeno un pallone nella sua vita, alzi la mano. Finora, francamente non ne ho conosciuto nessuno.
Ma ci si divertiva tanto e la fine delle ostilità era decretata quasi sempre dalle minacce fisiche o dalle promesse di pene corporali di qualche mamma o di qualche papà che intimavano al figlio di salire a casa e di mettere fine alla contesa. “Vabbè, picciò, ci vediamo domani” era il saluto che sanciva il triplice fischio e la promessa di nuove sfide, nuovi gol e nuove avventure.
Articoli correlati
Articoli correlati mobile
Le risposte che Monreale merita
MONREALE, 31 dicembre – Gli eccessi alimentari che caratterizzano le giornate in molte delle case del nostro territorio non devono farci distogliere lo sguardo da ciò che ci ha detto e ci ha lasciato quest’anno in eredità.