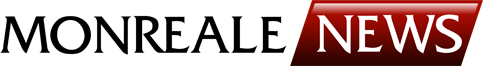''U patri e a matri si susinu di notti, appiccianu i lumi e conzanu i morti''
Pubblichiamo una bella novella su un tema sempre caro e sentito nel nostro costume
Quando ero picciliddra di manco sei annuzzi, subivo il fascino del giorno dei morti ancor più del Natale, eppure a Natale i giocattoli erano più corposi e, soprattutto, erano quelli che avevo chiesto a Gesuzzu e che lui mi avrebbe portato in base al mio comportamento diciamo, nell’ultimo mese.
Ora, io ero una bambina ubbidiente, ma anche camurruseddra, infatti, amavo trascorrere le giornate o a cantare o a piangere senza motivo, facendo pensare a tutti e, soprattutto, alla mia povera mamma, che ero una bambina dal cuore triste.
Questo, insieme al fatto che parlavo pochissimo e non mangiavo quasi niente, faceva di me la destinataria di giocattoli meritatissimi.
Il Natale, per me, poi era sopravvalutato: una festa di parenti affamati interessati solo alla pasta al forno e alla salsiccia col sugo.
Erano i tempi delle famiglie allargate in cui si cresceva con i cugini e ci si divertiva un mondo, ma io no, perchè essendo figlia del più grande dei fratelli, avevo cugini troppo piccoli e così a Natale non mangiavo, perché odiavo il cibo; non parlavo, perché preferivo ascoltare la voce dei miei pensieri e non piangevo, perché non avendone motivo mi avrebbero dato il resto.
La festa dei morti, al contrario, aveva un fascino sinistro che metteva i brividi, ma non quelli scantusi provocati dai lampi di notte, quando con la loro furia illuminavano gli specchi a giorno, ma quelli piacevoli, perché i morti che ci venivano a trovare erano parenti e non potevano che volerci bene.
L’importanza del regalo era direttamente proporzionale dalla strittanza della parentela col morto.
“Non si può pretendere” sentii dire a mio padre “ che un parente alla lontana possa spendere tanti picciuli per qualcuno che, magari, non ha neanche frequentato”
Certo, col senno del poi, sicuramente mio padre stava di “tutt’altri discorsi discorrendo”, ma io sentii questo ragionamento due giorni prima della festa e ne trassi le debite conclusioni. Naturalmente avrei potuto fare qualche domanda, ma siccome per parlare pareva che mi dovevano pagare, muta rimasi.
Tuttavia, questa informazione mi portò ad un’unica conclusione e cioè che a me servivano dei morti con una grande strittanza parentale che avrebbe aumentato l’amurusanza d’affetti con conseguente regalo più grosso.
Quando in prima elementare le mie compagne raccontavano alla maestra di avere solo due nonni o, addirittura nessuno, io pensavo che fossero molto fortunate mentre io, sfigatissima, i nonni li avevo tutti e quattro e così non mi restava che sperare che qualcuno di loro passasse a miglior vita in tempo per godersi la festa con i nipoti.
Non avevo ancora, per mia fortuna, il concetto della morte e così, per es. mi chiedevo perché in quel giorno di festa gli occhi di mia madre erano tristi per la morte “fortunatissima” di quel suo fratello che io non avevo mai conosciuto e che l’anno prima mi aveva portato un fitusissimo portamonete marrone che non si poteva guardare e una tavoletta di cioccolato con le nocciole che non ho potuto mangiare perché dice che faceva venire la carie.
Miii! Sta carie era un incubo!
L’unica risposta che trovai per le lacrime di mia madre fu che gli adulti, non avendo più interesse per il gioco e per i giocattoli, cosa inconcepibile per me, si dedicavano più ai rapporti umani legandosi in modo egoistico a chi sarebbe stato più felice da morto.
I morti, però, quando si fissavano su una cosa, quella doveva essere e non c’erano santi! Per es. i bambini monelli venivano puniti grattuggiando loro i piedi. Che poi, pensavo, il sangue dei piedi doveva essere un poco fituso considerata la posizione. Mi ripromisi, allora, che una volta morta io avrei deciso di grattugiare un gomito o un ginocchio al massimo chè non si sa mai il grado di pulizia delle persone.
Tuttavia, datosi che ancora ero viva, mi costringevo a dormire con i piedi coperti e accussì continuai per tutta l’adolescenza e parte della mia vita di adulta; lo stesso fecero intere generazioni di persone razionalissime e colte: docenti universitari che, prima di dormire, toglievano le grattugie da piedi piedi, chè non si sa mai.
Comunque per si e per no, io mi facevo la croce tre volte con tutte e due le mani e recitavo la filastrocca che mia nonna Catalda mi aveva insegnato
“Armi santi, armi santi
Iu sugnu sula e vautri siti tanti
Mentri sugnu n’tra stu munnu di guai
Cosi di morti mittitiminni assai”
Certo cose da mangiare non ne volevo, ma “Chi non accetta non merita” diceva mio nonno Antonio e io non volevo offendere nessuno, tanto meno un morto.
La cena del 31 pareva non finire mai, con tutte quelle battute di parenti spiritosi di cui ogni famiglia, purtroppo, è dotata.
“Ah, se potessi mangiare io e rimanere sicca come a tia!”
“Talè chi è sicca! U Signuri duna pani a cu un avi denti”
“Mangia, tu che sei sicca; mangia tu che puoi!”
Mai a nessuno venne in mente che, forse, io ero sicca appunto perché non mangiavo?
Comunque, quelle cena avevano l’effetto di un “consulu”, ma per fortuna arrivava la fine di Carosello, che era la linea di confine tra la veglia e il sonno e noi bambini andavamo a letto.
Certo, l’idea di questi fantasimi che col vestito della festa e i capelli impomatati passeggiavano nelle strade buie e silenziose, arrivavano al Calvario di Favara e poi entravano nelle case per portare i regali, non favoriva sicuramente il sonno, ma alla fine sempre picciriddi eravamo e stanchi e sudatizzi ci addormentavamo, scantati e speranzosi in quella strana notte ai confini della realtà.
Arrivava, poi, la mattina dei morti.
Meraviglia!
Il tavolo lungo, coperto da una la tovaglia di burano ricamata con un filo dal colore oro splavido,
reggeva tre alzatine in ceramica dalle quali grappoli d’uva Italia e minne di vacca, scendevano stanchi come in una natura morta del Caravaggio. All’interno di due cannistri, sopra la ritagghina bianca e oro, riposava la frutta martorana; la migliore pasta di mandorle, raffinata e soave, che simboleggiava quanto di bello i morti avevano visto sulla terra e che aveva preparato con mani esperte e piene d’amore mia zia Giannina.
I piatti in ceramica provenzale con meravigliosi fiorellini blu, erano ricoperti di taralli colorati, delicati tetù, rametti di miele, mustaccioli odorosi di vin cotto, biscotti regina interamente ricoperti di sesamo e ussiceddra di mortu che non si potevano mangiare, tanto eranu duri.
Sullo sparecchiatavolo, una cesta di vimini coperta da una tovaglia a quadri bianchi e rossi, nascondeva profumatissimi muffuletti appena sfornati, pronti per essere cunzati con olio, sale e pepe.
C’era tanta roba da sfamare un esercito di vivi e pure di morti.
Nascosti da qualche parte i regali deludenti dei miei defunti parenti alla lontana.
Un anno in particolare, dopo aver scartato l’ennesima cucina di plastica che già allora odiavo, mi preparai mentalmente ad assistere alla tragedia che sarebbe accaduta di lì a poco.
Mio padre, comprava “per tempo”, (un mese prima) i cosidetti pupaccena di zuccaru raffiguranti dame e cavalieri che, in quanto nobili d’aspetto e d’animo, tenevano per così dire la porta aperta per consentire ai morti di passare da un mondo all’altro andata e ritorno.
Ci proibì di toccarli elencando le punizioni che ci avrebbe impartito nel caso li avessimo anche solo sfiorati e li dispose in bella vista nella cristallera chiusa a chiave.
Quelle pupe antropomorfe dai colori sgargianti sembravano brillare in mezzo ai bicchieri buoni e ci guardavano con il loro eterno sorriso e tanto di quello zucchero che faceva alzare la glicemia solo al pensiero di assaggiarne un pezzo.
Questo atteggiamento di mio padre, mentre veniva tollerato con pazienza da mia madre che era una santa, ma anche da me, chè i pupi mi facevano schifo nella forma e nel sapore, era, tuttavia, vissuto come un’autentica ingiustizia dalle due mie sorelle che erano un poco più grandi di me e che, dopo avere scoperto il nascondiglio segreto dove mio padre teneva la chiave col giummo rosso (in una delle tazze da the di nonna Catalda…mi, fantasia!), giorno dopo giorno, come surciteddi di campagna, avevano muzzicato e rusicato la parte posteriore dei pupaccena fino a lasciare solamente la lastra colorata che stava addritta pi scummissa.
A tavola, mio padre, mia madre e nonna Catalda erano seduti con le spalle verso la cristallera, mentre noi figlie proprio di fronte ai pupaccena.
Me soru Francesca che era la più grande dei figli e con un’attitudine alle strurusarie che lo poteva fare di mestiere, controllava preoccupata e divertita i pupi che parevano abbuccare ora a destra, ora a sinistra, ma che alla fine, miracolosamente riuscivano a mantenere l’equilibrio.
La pasta al forno riempiva l’aria di un arcobaleno di odori di mozzarella, tuma, uova sode, prosciutto e piselli inondati di sugo fresco delle conserve, mescolati all’odore delle paste Elena, delle sfincie e cialdoni ripieni di finissima ricotta e interamente ricoperti di granella di mandorle e pistacchi, sapientemente incollati su una spennellatura di miele dolcissimo.
Tutti tranne me avevano l’acquolina in bocca.
Mentre mamma stava servendo una porzione esagerata di pasta al forno, da tutti definita come la più buona della Sicilia occidentale, da lontano arrivò un miagolio lamentoso e questo fece storcere il naso a mio padre rabbuiando quel suo sorriso simpatico sotto i folti baffi da vero siciliano.
Mia nonna Catalda, invitata a pranzo come in ogni festa comandata, si era amminchiata che quella volta non voleva lasciare da sola la jatta ca di nome faceva Calamitigei per via di un personaggio che aveva visto in un film e del cui nome si era innamorata perdutamente.
Mio padre, contrario alla presenza di animali a casa, aveva mussiato e si era anche murmuriato un poco, ma alla fine cedette perché sapeva che mia madre da santa, quando voleva, sapeva trasformarsi in diavula per rendergli la vita un inferno.
Accussì si fece quattro conti e alla fine abbassò la testa dal lato sinistro che nel suo gergo significava “Va bene, ma che non diventi un’abitudine”
Calamitigei era arrivata con quel suo fare jattesco, strusciandosi tra le gambe di nonna Catalda, coperte da una gonna grigia di due misure più grandi chè “Oggi domani ingrasso, me la ritrovo”.
Dopo aver odorato qua e là, si diresse in cucina e lasciò un’abbondante e puzzolente pisciazzata sotto il tavolo, giusto per fare capire chi era il capo.
La picciliddra si emozionò – esclamò mia madre, mentre lisciava il riporto di mio padre che, a causa della collara, stava diventando scomposto e sudatizzo.
Nonna Catalda prese in braccio Calamitigei e le accarezzò il pelo morbido su quel musetto aristocratico
Ti emozionanasti? – le sussurrò dolcemente – Ora, però, la brava devi fare chè sennò i morti non ti portanu niente! –
Ma picchì, pure lei riceve un regalo? –
A mio padre stava venendo un travaso di bile
E certo – rispose mia madre mostrando i denti davanti un poco macchiati di rossetto chè non ci era abituata
Nonna Catalda aprì la sua borsa che era grande assai per via che da giovane aveva fatto la levatrice e, oramai, si era abituata così e ne estrasse un pacchetto confezionato con il fiocco. Lo posò delicatamente sullo sparecchiatavolo, si sistemò la messenpiega in quel grande specchio che distorceva un poco le immagini e si sistimò a tavola accanto al posto di mia madre, lisciandosi la gonna.
Non c’è bisogno che mi aiuti, mammì –
si sentì dire dalla cucina, ma a giudicare dalla smorfia che fece nonna Catalda, ella non aveva mai avuto la minima intenzione di dare una mano forse perché, come amava dire spesso, la criata nella sua vita non l’aveva fatta mai, neanche ai figli.
Calamitigei era stata chiusa in una stanza per consentire agli astanti di pranzare, ma come fu e come non fu, essa riuscì ad abbassare la maniglia ed uscire.
Spuntò con fare languido in camera da pranzo e iniziò a strofinarsi tra le gambe di mia madre prima e…tra le cannelle di mio padre poi. Non l’avesse mai fatto: il riporto di papà, lucido e impomatato sembrò rizzarsi, forse ancor di più del pelo di Calamitigei quando mio padre la spinse con una carcagnata. La jatta fece un salto che nel futuro sarebbe stato paragonato solo a quello di Sandokan il giorno in cui uccise la tigre di Monpracen e sfiorò la credenza un attimo prima di sparire nel corridoio.
La cristallera ebbe un brivido e fece tintinnare i bicchieri di cristallo e le tazzine con il bordo in oro zecchino che mia madre aveva diligentemente lucidato.
Fu allora che il primo pupaccena, raffigurante San Giorgio, ebbe un sussulto e non essendo sostenuto dalla parte posteriore, abbuccò come a rallentatore sugli altri pupi provocando, in un tragico effetto domino, l’abbuccamento degli altri tre, mostrando così il rusicamento della parte posteriore e frantumandosi nella sostanza e nell’orgoglio come un pupo qualsiasi.
Io mi stavo divertendo come mai era accaduto, così come le mie sorelle che, già consapevoli della punizione ne che sarebbe seguita, si stavano scassando dal ridere con le lacrime davanti alle bocche aperte di mia madre e mia nonna e al riporto scomposto di mio padre che mostrava una tristissima tigna incipiente.
Panico, mentre il tempo parve fermarsi.
Mio padre, allora, si lisciò i capelli, si assittò di nuovo e, con sorpresa di tutti, mise una cucchiaiata di pasta al forno in bocca.
Miiiii! – disse, allora, soddisfatto – A questa pasta tua, Cecè, ci manca solo la parola! –
Poi, piano piano, in un crescendo che non avevamo sentito mai, iniziò a ridacchiare finchè la sua risata argentina non esplose, coinvolgendo tutti noi e, forse, pure la jatta.
Fuori, un venticello fresco creava mulinelli, spampazzando le prime foglie secche e arancioni che da noi in Sicilia, cominciano a farsi vedere a novembre e la gente già si preparava a far visita ai propri cari al cimitero, per rendere quelle lapidi fredde, dei giardini odorosi e per ricordar loro che i legami d’amore che avevano lasciato sulla terra, erano e sarebbero stati per sempre, vivi e pulsanti.
Chi ti purtaru i morti? –
Mi chiese una signora, mentre timida, mi nascondevo tra le gambe di mia madre
Un pupu cu l’occhi torti –
Risposi con occhi furbi prima di affidarmi alla vita e ai suoi stupori.
Agneddu e sucu…
Le risposte che Monreale merita
MONREALE, 31 dicembre – Gli eccessi alimentari che caratterizzano le giornate in molte delle case del nostro territorio non devono farci distogliere lo sguardo da ciò che ci ha detto e ci ha lasciato quest’anno in eredità.